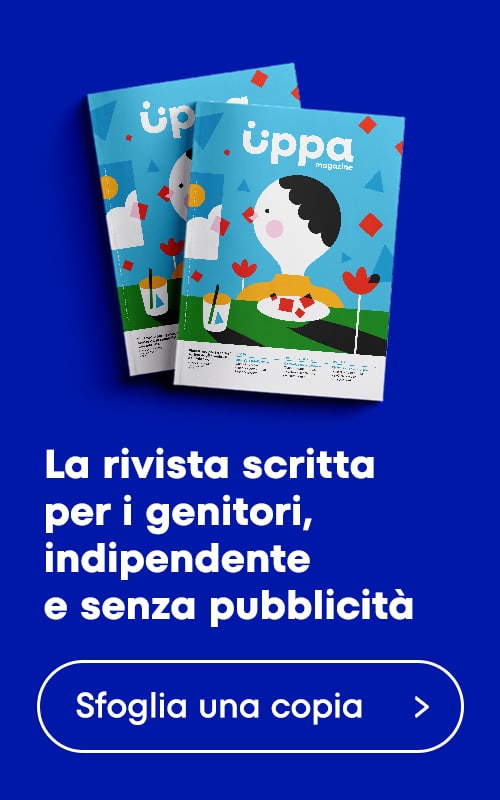L’obbligo vaccinale è davvero necessario?
L’introduzione dell’obbligo vaccinale riflette spesso un compromesso tra la tutela della salute pubblica e il contesto socio-culturale di riferimento, e rappresenta una sconfitta per chi si occupa, a vario titolo, di salute pubblica. Una discussione aperta e informata è essenziale per ragionare su misure che siano capaci di portare a un incremento della popolazione vaccinata senza ricorso alla coercizione

Le opinioni espresse dall’autore in questo articolo sono personali e non riflettono necessariamente quelle dell’istituzione di appartenenza.
Il calendario vaccinale italiano prevede per la prevenzione delle malattie infettive nei bambini la somministrazione di 15 vaccini, a cui si aggiunge il vaccino antipapillomavirus raccomandato per le ragazze e i ragazzi dopo il compimento degli 11 anni di età.
Alcuni di questi vaccini sono obbligatori, altri raccomandati. Perché esiste questa differenza? È una domanda a cui non è semplice fornire una risposta, ma soprattutto è difficile chiarire che la scelta di imporre un vaccino obbligatorio non è orientata da dati oggettivi ottenuti nel corso di studi scientifici, ma da ragioni di politica sanitaria.
Vaccini obbligatori in Italia
Facciamo un breve excursus per capire da dove nasce l’obbligo delle vaccinazioni nel nostro Paese.
In Italia, fino al 2017 esistevano 14 vaccini disponibili per l’infanzia (sostanzialmente gli stessi di oggi, con l’eccezione di quello antinfluenzale che non era ancora raccomandato). L’obbligo vaccinale riguardava solo l’antidifterite, l’antipolio, l’antitetano e l’antiepatite B. Tranne quest’ultimo, introdotto nel 1991, gli altri vaccini erano stati introdotti tra gli anni Trenta e gli anni Sessanta, in un contesto sociale e di salute molto diverso da quello attuale, in cui era frequente che gli interventi di sanità pubblica fossero accompagnati da misure coercitive, allo scopo, anche, di fronteggiare in tempi brevi malattie con possibili conseguenze molto gravi.
Prima delle vaccinazioni di massa, ogni anno in Italia si registravano circa 10.000 casi di difterite e 3.000 di paralisi da virus della poliomielite. Si trattava, quindi, di malattie con un impatto sulla popolazione tale da giustificare un vaccino obbligatorio per queste malattie. Dopo l’inizio delle campagne vaccinali l’incidenza di queste malattie si è drasticamente ridotta: per quanto riguarda la poliomielite, l’ultimo caso di infezione da virus selvaggio è stato segnalato nel 1982.
Alla luce del cambiamento della situazione epidemiologica, che aveva visto una netta diminuzione delle malattie infettive grazie ai vaccini, e di un nuovo contesto socio-culturale, si era cominciata ad avvertire la necessità di superare il concetto di obbligo delle vaccinazioni, per privilegiare l’adesione consapevole e informata alla vaccinazione da parte dei genitori; questo approccio è stato sperimentato concretamente, a partire dal 2007, nella regione Veneto, che per dieci anni ha sospeso l’obbligo vaccinale.
Nel corso del 2017, però, si è assistito a un nuovo cambio nelle politiche vaccinali: con un decreto legge del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, poi convertito in legge (119 del 31 luglio 2017), i vaccini obbligatori passano da 4 vaccini a 10 e vengono combinati in due vaccinazioni:
- esavalente (contro difterite, tetano poliomelite, epatite B, pertosse, Haemophilus influenzae di tipo b), somministrato in tre dosi nel corso del primo anno di vita (con successivi richiami per difterite-tetano-pertosse-polio)
- tetravalente (anche conosciuto come vaccino MPRV, contro morbillo, parotite, rosolia, varicella), somministrato tra i 12 e i 15 mesi di età e successivamente con una seconda dose tra i 5 e 6 anni.
I bambini non vaccinati non possono frequentare asili nido e scuole per l’infanzia, mentre è consentita l’iscrizione alla scuola primaria e secondaria. Per i genitori sono previste sanzioni amministrative.
L’estensione riguardante la vaccinazione obbligatoria è stata introdotta per la preoccupazione dovuta al calo della percentuale di bambini vaccinati, in particolare contro il morbillo, una malattia altamente contagiosa e con possibili conseguenze gravi (polmoniti, encefaliti), potenziali danni a lungo termine e rischio di morte, soprattutto nei soggetti che hanno un sistema immunitario indebolito.
Per evitare che il virus del morbillo circoli all’interno di una comunità è necessario che il 95% delle persone sia immune (per vaccinazione o per aver già contratto l’infezione): nel 2016 i bambini di età inferiore a 2 anni vaccinati contro il morbillo erano l’87%, una quota ben al di sotto della soglia che garantisce l’immunità a tutta la comunità.
Vaccini raccomandati
L’obbligatorietà del vaccino antimorbillo, dunque, tutela i soggetti fragili (ad esempio chi è in cura per un tumore) che non possono vaccinarsi e che correrebbero gravi rischi se dovessero ammalarsi.
Occorre, però, chiarire che negli altri casi l’estensione dell’obbligo vaccinale non ha avuto come motivazione preponderante la tutela della comunità, ma si è trattato di un intervento pragmatico, dovuto al fatto che in Italia (e lo stesso vale per molti altri Paesi europei) non sono disponibili vaccini singoli, ma solo combinati. Ad esempio, già prima del 2017 l’esavalente, nella pratica, era una vaccinazione obbligatoria, nonostante due dei vaccini che contiene non lo fossero, perché era estremamente difficile vaccinarsi soltanto contro la poliomielite, il tetano, la difterite e l’epatite B.
Se poi alcuni vaccini, oggi, sono raccomandati e non obbligatori, non significa che siano meno importanti, ma semplicemente che portano beneficio alla salute del singolo più che alla comunità nel suo complesso, per cui non è giustificata la coercizione.
Nello specifico, oltre ai vaccini obbligatori, tra i vaccini consigliati troviamo quelli contro:
- rotavirus;
- pneumococco;
- alcuni tipi di meningococco (B e ACWY);
- antinfluenzale;
- antipapillomavirus (raccomandato tra gli 11 e i 12 anni di età).
Obbligo vaccinale: qual è la situazione a livello europeo?
La maggior parte dei Paesi europei ritiene che le ricadute negative dell’obbligo siano maggiori dei potenziali benefici: 18 dei 30 Stati che fanno parte dell’Unione Europea e dello spazio economico europeo (EEA) non prevedono vaccini obbligatori. Con l’eccezione di Francia, Italia e Malta, ad avere l’obbligo vaccinale più esteso sono i Paesi dell’Est Europa che facevano parte dell’URSS.
Anche tra i Paesi che hanno deciso di adottare l’obbligo vaccinale, comunque, il numero e il tipo di vaccini varia. Quello contro la poliomielite è l’unico obbligatorio in tutti i 12 stati, mentre quello con il morbillo è obbligatorio in 11. L’antivaricella, invece, è obbligatorio soltanto in Italia, Lettonia e Ungheria, mentre la Francia, allo scopo di evitare confusione, ha deciso di rendere obbligatori tutti i vaccini dell’infanzia previsti nel suo piano vaccinale (esavalente, morbillo-parotite-rosolia, antipneumococco e antimeningococco C), diventando così l’unica nazione europea ad aver previsto l’obbligo per il vaccino contro il meningococco C.
In generale, non c’è correlazione tra la presenza di obbligo vaccinale e la percentuale di bambini vaccinati: si osservano coperture elevate anche in Paesi che non hanno vaccini obbligatori e, viceversa, Paesi che prevedono l’obbligo possono avere coperture insufficienti.
L’obbligo vaccinale è efficace?
A distanza di cinque anni dall’introduzione dell’obbligo vaccinale in Italia le coperture sono aumentate, soprattutto per il vaccino contro il morbillo: dall’87% del 2016 al 94% nel 2022. Si potrebbe, quindi, concludere che l’obbligo è utile e necessario, ma si tratterebbe di un’interpretazione sbrigativa: la situazione è un po’ più complessa di così. Anche se utile, infatti, la misura dell’obbligo, da sola, non è sufficiente per garantire il raggiungimento dell’immunità da parte della popolazione. Il 94,4% di vaccinati registrato in Italia non restituisce l’estrema variabilità regionale, che presenta un intervallo compreso tra il 76% e il 98%; solo in 6 regioni è stata raggiunta o superata la soglia del 95% necessaria per impedire la circolazione del virus.
Al di là dell’obbligo, dunque, è necessario intervenire con altre misure che favoriscano la vaccinazione: ad esempio, migliorare l’informazione e la comunicazione perché si acquisisca maggiore consapevolezza dei benefici ottenibili con i vaccini, migliorare l’accesso a questi ultimi (con un’adeguata diffusione sul territorio e orari compatibili con gli impegni quotidiani) e migliorare anche l’accoglienza degli operatori sanitari e dei luoghi in cui avviene la vaccinazione.
L’esitazione vaccinale, infatti, è un fenomeno complesso, ed è sbagliato ritenere che tutti i genitori che non vaccinano lo fanno perché ideologicamente contrari alle vaccinazioni: il dato che emerge dalle indagini campionarie condotte in Italia è che la quota di genitori fortemente contrari a qualsiasi vaccino è compresa tra l’1 e il 3%, mentre il 15% nutre dubbi o timori nei confronti di alcune vaccinazioni.
L’obbligo vaccinale, quindi, rischia di rappresentare una risposta semplicistica, mentre la questione richiede una pluralità di interventi. Gli esperti che si occupano di politiche vaccinali sottolineano i potenziali rischi delle misure coercitive: queste ultime rischiano ad esempio di ridurre una fiducia già compromessa verso i medici e le istituzioni, polarizzano ulteriormente le posizioni, aumentano la confusione, e spingono i genitori esitanti verso una più netta contrarietà.
Si tratta di problemi che sono emersi con forza durante la pandemia di Covid: l’adozione del green pass e l’introduzione dell’obbligo del vaccino per gli over 50 ha accresciuto il risentimento nei confronti delle istituzioni sanitarie di una parte della popolazione, numericamente esigua ma costituita anche da persone che, non contrarie pregiudizialmente ai vaccini, nutrivano preoccupazioni verso quel tipo specifico. Occorre quindi valutare accuratamente gli impatti sia positivi sia negativi delle misure di obbligo vaccinale, anche per essere in grado di pianificare strategie efficaci in caso di future emergenze di salute pubblica.
La vaccinazione obbligatoria non è un dogma
Che le vaccinazioni debbano essere obbligatorie non è un dogma. In alcuni contesti (storici, territoriali, culturali) inserire l’obbligo vaccinale può essere una misura utile per tutelare la salute della comunità, ma bisognerebbe pianificare e attuare altri interventi con la prospettiva, in futuro, di eliminare le misure coercitive.
C’è consenso tra chi si occupa di vaccinazioni nel ritenere che le misure coercitive dovrebbero rappresentare una extrema ratio a cui ricorrere quando altri interventi non sono risultati sufficientemente efficaci o quando non c’è il tempo necessario per metterli in pratica, e dovrebbero comunque essere adottate per un periodo limitato di tempo. È bene tenere sempre a mente che il ricorso alla vaccinazione obbligatoria rappresenta una sconfitta per chi si occupa di salute pubblica a differenti livelli (politici, amministratori, operatori sanitari) e per tutta la collettività. Occorre infine ribadire che è del tutto legittimo discutere dell’obbligo vaccinale, ma quando lo si fa solamente per interessi politici o sulla base di pregiudizi il dibattito è sterile e controproducente.
medico e specialista in Farmacologia Clinica, ricercatore presso il Laboratorio per la Salute Materno Infantile dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS di Milano, dove è responsabile dell’Unità di Farmacoepidemiologia. Si occupa principalmente del monitoraggio dell’uso dei farmaci nei bambini e negli adolescenti e del trasferimento dell’informazione sull’impiego dei farmaci, in particolare per quanto riguarda la gravidanza, l’allattamento e l’età pediatrica, agli operatori sanitari e ai cittadini.
Immagine in apertura scyther5 / iStock